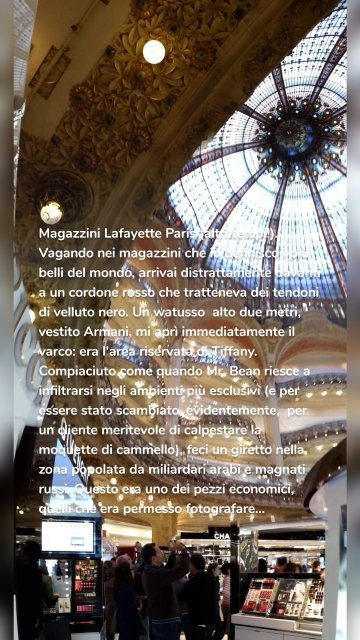IO, LA LUNA, EMILIO E LA VIC
(Diario di viaggio)
Prologo
“A Genova dicono che la Vic, come si fa chiamare dai suoi innumerevoli amanti, vent’anni fa era la più bella di tutte. Emilio, scrittore e pittore famoso, affascinante anche lui ma già in età matura, l’aveva vista nascere e l’amò intensamente. Le lasciò una sua opera, pur conscio che non sarebbe stata mai solo sua e che Lei, di quel dono prezioso, se ne sarebbe fatta vanto con tutti quelli che sarebbero venuti dopo di lui”.
Diario
La gente si è attardata nei locali e nei bar, sotto insegne altisonanti e pretenziose: Concorde Plaza, Gran Bar Orpheus…, indugiando davanti ai boccali vuoti di birra e ai bicchieri da cocktail con due dita di ghiaccio sciolto sulle foglie di menta. Poi si è spenta l’ultima chiacchiera, quella che anticipa i pochi secondi di mutismo che precedono i saluti. Qualcuno ha provato a mantenere ancora viva la notte, ma si è pentito di aver bruciato l’aneddoto più significativo del suo repertorio, o la sua barzelletta più nuova, davanti a una sparuta platea di amici, visibilmente insonnolita e ormai disattenta.
I camerieri iniziano a sistemare le sedie intorno ai tavoli vuoti e a passare i panni di microfibra sui vetri e sugli intarsi dei marmi, dapprima con circospezione, per non creare disagio ai clienti ritardatari, poi sempre con maggiore decisione. Fisicamente provati, anche loro, da un sabato da tutto esaurito – anche se qui c’è il pienone in tutti i giorni della settimana – ora possono finalmente smettere il sorriso d’ordinanza. Tra poco potranno anche sbottonare il colletto rigido e togliere il giacchino stretto. Il più giovane di tutti, sotto il suo ciuffo corvino, conserva ancora, però, le energie sufficienti per fare delle battute spiritose in inglese, con un occhio rivolto a una collega, una ragazza minuta con la pelle ambrata e dagli accattivanti tratti orientali. Immagino che il ragazzo stia pensando che questa possa essere la notte giusta, quella in cui il sogno più incontenibile sfuggirà all’impossibile e tracimerà nella realtà, quella in cui la sua Jasmine accetterà di farsi accompagnare e salterà con lui su un tappeto volante (e il mondo sarà loro…). Il suo capo barman, mentre risciacqua uno shaker, lo osserva con un’aria di disapprovazione che non si capisce se sia invidia o istinto paterno di protezione verso la bella dagli occhi a mandorla.
A mano a mano che le ultime persone escono dal locale, che l’ambiente viene ripulito e riordinato, mentre l’odore artificiale del detergente si diffonde nell’aria contrastando l’aroma, ancora persistente, degli ultimi caffè serviti al banco, la luce preziosa dei lampadari di Murano e quella precisa, quasi tagliente, dei faretti incassati nei ribassi del soffitto si riappropria degli spazi lasciati vuoti, ridefinisce i contorni degli arredi e mette in risalto le architetture dai colori vivaci, si riflette sugli specchi e sulle vetrate. Gli interni, ridisegnati dalla luce, appaiono dilatati, malinconici e solitari come nei quadri di Edward Hopper. E, come nella tela che ho in mente, il buio fuori, oltre le pareti di cristallo, è totale e funzionale a esaltare i contrasti. Esco all’aperto.
Dei gruppetti d’insonni provano a fare due passi ma non si è mai visto un inizio di giugno più fresco e il vento costante e l’umidità della notte non si conciliano con le spalle scoperte delle donne e i loro vestitini corti, con le bluse scollate e intessute di lustrini, con le camicie degli uomini di lino fine, portate fuori dai pantaloni e ormai stazzonate dalla sosta prolungata sui divani dei locali. Il cielo è uniforme e grigiastro perché un velo di foschia trattiene la luce, lo scherma e lo rende avaro di stelle. Solo di tanto in tanto, alzando gli occhi, ci si accorge che la foschia si è diradata, a tratti si è strappata, e sta lasciando intravedere uno scampolo scuro, profondo e scintillante.
Cosa si aspettano questi nottambuli che vagano senza meta, cosa mi aspetto anch’io, da questa strana notte che precede la luna nuova? La luna è lì, da qualche parte, oltre la cortina di vapore freddo. Un sottile semicerchio che ci scruta pur serrando gli occhi, inosservata, con la faccia ormai dipinta di nero, quella che ci fa rabbrividire – come un cattivo presagio – quando si rivela in una carta dei tarocchi assegnataci dalla sorte, ma anche quella che prepara le energie della Terra e che cova, per ognuno di noi, i fatti rilevanti che accadranno nelle sue fasi successive. Forse adesso è ancora più magica di quando la vedremo nuovamente, più avanti, in tutto il suo splendore e, favorendo il moto delle maree, riempirà le reti di pesci. Quando scandirà il tempo di nuove battaglie, scatenando l’aggressività, ma anche la vitalità e la voglia di fare degli uomini e degli altri esseri viventi. Al suo chiarore accadranno le cose, i baci degli innamorati saranno più intensi ma anche le storie fantastiche, popolate di fantasmi e licantropi, appariranno più credibili, ma non è questo il momento. Questo è, evidentemente, il tempo e l’ora in cui la luna segretamente concilia gli incontri, favorisce l’introspezione e la riflessione. La cameriera ha slacciato il fiocco del suo grembiule da pub e ha tolto la bustina che aveva sul capo, sciogliendo sulle sue spalle una massa di capelli setosi. Ora il ragazzo con il ciuffo le cammina di fianco, quasi proteso verso di lei, ma senza toccarla, temendo che l’incantesimo svanisca o che il capo, domani, lo riprenda perché le regole sono ferree e non sono ammessi rapporti sentimentali fra i dipendenti.
Anch’io ho un appuntamento, questa notte, forse anch’esso favorito dalla luna nera, anche se definirlo tale è inappropriato. Non è questo il motivo perché io sia qui ma devo confessare che arrivavo già preparato e ho evitato di scontrarmici, tenendo bassi gli occhi apposta, per non guardare e non bruciarmi in anticipo un piacere al quale intendevo riservare un momento di tranquillità. Questo pomeriggio c’era fin troppa gente e certe situazioni, invece, meritano la quiete e il silenzio. So che posso confidare nelle persone che mi accompagnano e che condividono con me le esperienze più significative della vita. Sanno che devono lasciarmi aumentare il passo, e farmi andare avanti, oppure consentirmi di rallentare, e rimanere indietro. Bastano pochi istanti, quelli che mi occorrono per confrontarmi, senza l’influenza di altri, con l’inquadratura di una foto, con lo sguardo o con un gesto significativo di una persona, davanti a un panorama inaspettato o a un’opera d’arte la cui visita è stata fortemente desiderata.
L’ampia sala è stata arredata strizzando l’occhio ai colori della pop art. Qui le luci non sono diffuse ma sono sapientemente dirette alle pareti. C’è un motivo: qui parlano i muri. Il mosaico di Emilio Tadini, che tanto ho aspettato di ammirare, mi avvolge su tutti i lati. Mi chiedo se, per interpretarlo, ci sia un ordine da rispettare. Le scene che mi appaiono sono complesse, ricche di personaggi e di simboli e l’opera è un rebus non facilitato. Che importa da dove partire? Ci sarà tempo per ritornare, riflettere e interpretare. Allora mi approccio istintivamente alla “pittura fantastica” del Maestro, al cielo piatto di tessere azzurre, turchesi e smeraldo, alle proporzioni invertite, alle strane prospettive e all’asimmetria, agli acrobati stilizzati dalle braccia e gambe disarticolate che si allungano nel paesaggio come ponti, che sembrano giocare fluttuando nell’aria, che scavalcano i palazzi, pronti a saltare, con una nuova piroetta, fuori dal mosaico, inondando l’ambiente di colori clowneschi. Sarebbe, comunque, un’invasione gioiosa e pacifica perché, come affermò più volte Tadini, parlando dei suoi quadri fantastici, “Il mio colore non sarà mai violento…”.
Sapevo che l’avrei trovato al Bar Capriccio e che ne adorna e impreziosisce le pareti fin da quando è stato inaugurato, nel lontano 1996 (pochi anni dopo Emilio Tadini, classe 1927, scrittore, poeta, pittore, indimenticato Direttore dell’Accademia di Brera, sarebbe morto), ma ero pienamente cosciente che era un posto difficile da trovare nella vita reale perché, coerentemente con il suo nome, non è mai nello stesso luogo, non ha un indirizzo e un codice di avviamento postale, né è mai dove noi vorremmo che fosse.
Su una pedana, addossata a un muro, c’è un pianoforte a coda bianco con le corde ancora calde. In quella sala c’è stato un pianista che si è esibito fino a poco prima. Ha guardato la gente seduta ai tavoli e ha adattato il suo repertorio all’età e alla nazionalità degli ospiti. Ha tenuto da parte, confidando nel successo della serata, qualche cavallo di battaglia per un’eventuale richiesta di bis, come se le persone fossero lì per lui e non per stordirsi di beveroni a base di rum. Vicino al piano, due grandi finestre si aprono verso Ovest. Mi avvicino ai vetri e mi faccio schermo con le mani intorno agli occhi, per azzerare il riflesso delle luci. Poi guardo l’orologio e faccio un rapido calcolo. Esco dal locale, mi affaccio a una balconata e aguzzo la vista. Vedo solo una striscia di luci traballanti all’orizzonte, troppo lontane e sfumate dalla foschia e dalle mie lenti a contatto, ormai appannate, per riconoscere Otranto. Però mi arriva, improvvisa, una folata tiepida di brezza di terra e mi illudo di riconoscere, in quel vento caldo, l’essenza della mia terra: il profumo dell’origano e della menta selvatica, l’odore balsamico della pineta che si distende lungo la litoranea e quello dei ginepri che trattengono le dune degli Alimini. La Sirena del Malepasso canterà inutilmente, questa notte mi befferò di lei. A sporgersi oltre il lecito, però, basta un attimo, quanto occorre per scorgere l’onda in costante avvitamento sul rostro che lacera il mare. È un’onda sollevata dalla spinta delle eliche che (citando vagamente Bertoli) si frange e si vaporizza sulla prora della Victoria, la “Vic” per i suoi innumerevoli amanti…
Epilogo
Ora non mi resta che continuare il mio giro notturno, ricongiungendomi ai miei compagni di viaggio. Abbiamo ancora da cercare la moneta che il capomastro ha saldato in una murata seminascosta di un ponte (perché la possano scoprire solo i più motivati). E’ il tributo che è stato pagato al momento del varo, perché la nave sia sempre protetta contro la mala sorte (e chi trova la moneta godrà di una protezione speciale)
(02/06/2019 – Dalla Victoria, in transito nel Canale d’Otranto, in lenta navigazione verso il Mar Egeo)